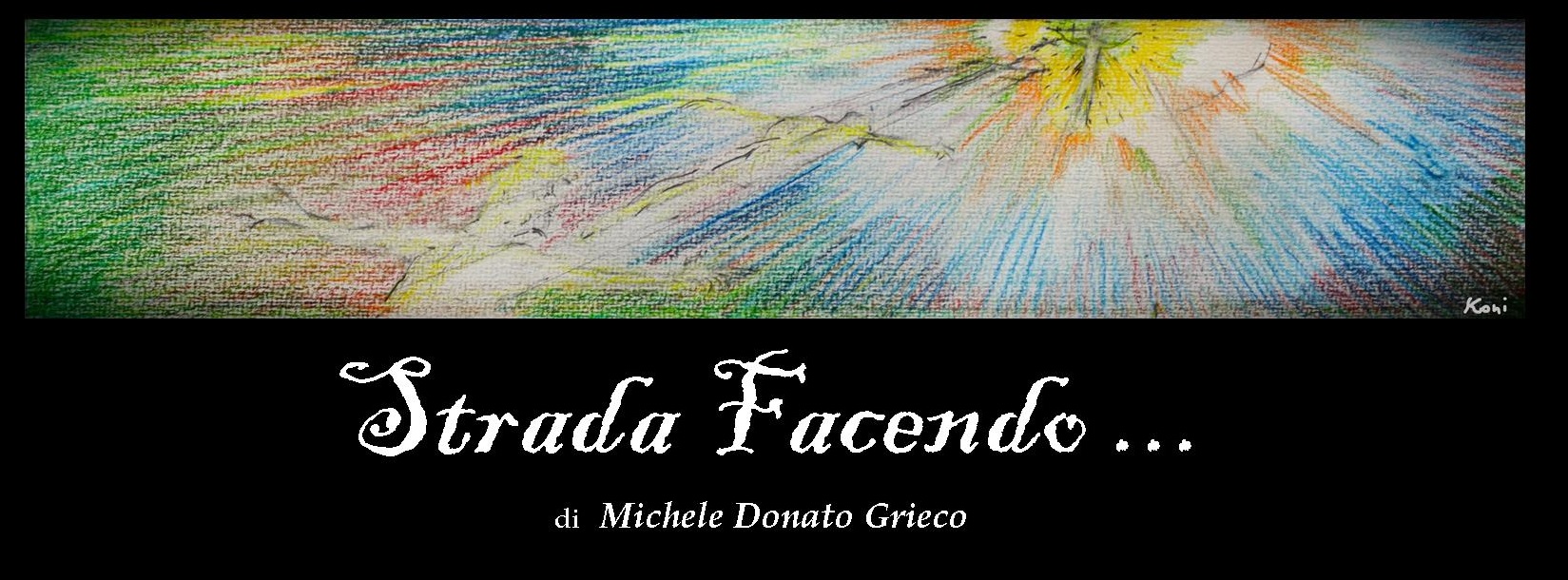
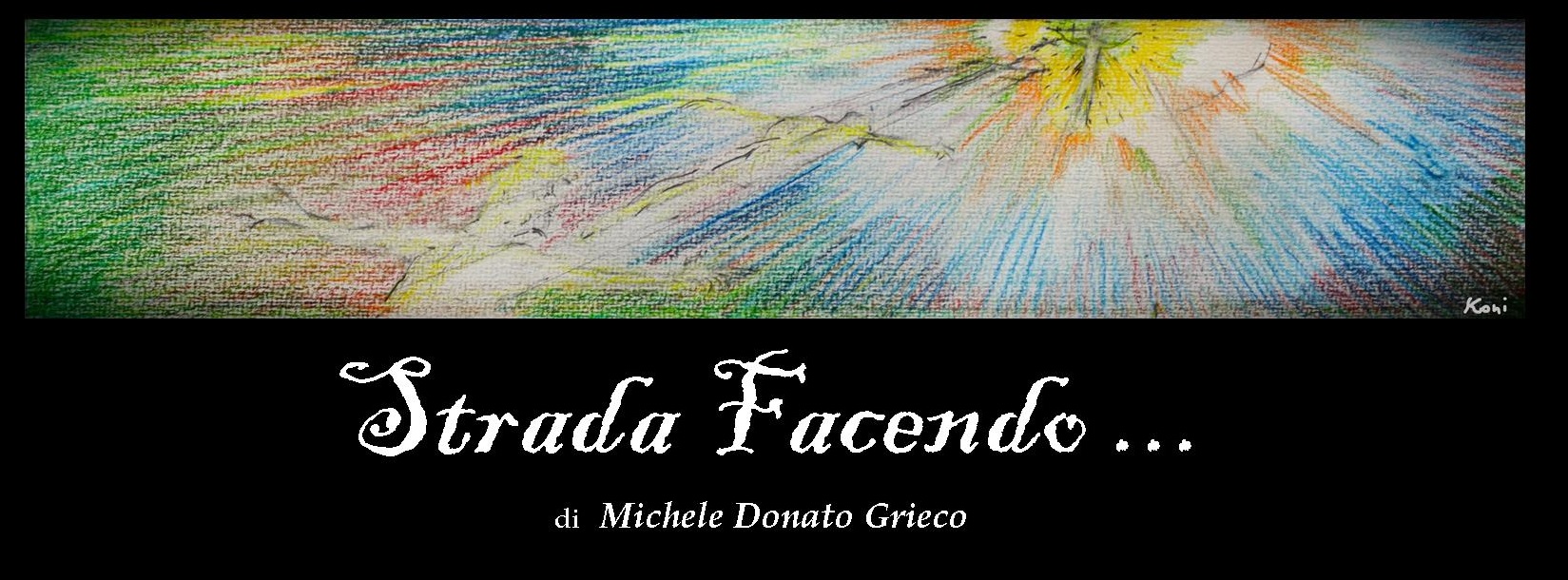
La socialità: essenza dell’uomo
«Avevo tre sedie nella mia casa;
una per la solitudine, due per l’amicizia, e tre per la compagnia».
tratta dal libro Walden ovvero Vita nei boschi di
Henry David Thoreau, nato David Henry Thoreau,
filosofo, poeta e scrittore statunitense,
(Concord, 12 luglio 1817 – Concord, 6 maggio 1862).
Ho, quest’oggi, casualmente riascoltato un proverbio dei miei tempi passati: «Meglio soli che male accompagnati».
È importante tener conto di quest’espressione, proveniente dall’antica sapienza e prudenza popolare, quando abbiamo il sentore d’essere circondati da persone poco raccomandabili che potrebbero danneggiarci in qualsiasi modo. È un monito che c’invita a fare scelte consapevoli riguardo le nostre relazioni, amicali e amorose, ma non è un’esortazione all’isolamento.
La solitudine interiore, infatti, è significativa solo quando dobbiamo decidere qualcosa di fondamentale, pur avendo ascoltato diversi pareri, perché l’essere umano non è fatto per stare solo.
Nella Bibbia leggiamo: «E Dio creò l’uomo a sua immagine; / a immagine di Dio lo creò: / maschio e femmina li creò. / Dio li benedisse e Dio disse loro: / Siate fecondi e moltiplicatevi, / riempite la terra e soggiogatela… Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona» (Gen 1,27–28.31).
L’uomo, quindi, immagine di Dio nella libertà, intelligenza, amore e comunione, è creato per amore, sul modello della comunione trinitaria, nelle Persone divine. Dio, infatti, aggiunge, «Non è bene che l’uomo sia solo» (Gen 2,18), creando gli esseri umani in comunione tra loro e, come tali, li ammette alla comunione con sé.
Il filosofo greco Aristotele1 con l’espressione «L’uomo è per natura un animale sociale» asserisce che l’istinto collettivo è insito in tutti noi.
Lo scambio di dialoghi, confronti, discussioni e opinioni, sviluppa nuove conoscenze e, quindi, idee che sempre incrementano la nostra fantasia e ci arricchiscono, contribuendo a formarci e a farci acquisire competenze.
Non troviamo, infatti, in noi il sapere, ma a scuola, in biblioteche, centri sociali, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, come nella meravigliosa natura che ci circonda e, soprattutto, nel nostro affine, la dolce metà.
«Animae dimidium meae» – «Metà dell’anima mia» (Odi 1,3,8)2, scrive Quinto Orazio Flacco3, poeta latino di Venosa, in riferimento alla parte essenziale della nostra esistenza, ossia la persona che amiamo.
L’aggregazione sociale, appunto, implica formare famiglia, oltre che fondare aziende, associazioni e fondazioni, studiare, ricercare, lavorare, giocare e divertirsi in squadra.
La reciprocità, inoltre, è costituita da cose semplici, ma essenziali per il nostro benessere psicologico, come scherzare, esultare e gioire.
È soltanto congiuntamente che si realizzano autentici obiettivi. «L’unione fa la forza», ci suggerisce un altro adagio, ricordandoci che nessuno di noi è del tutto autosufficiente: «Meglio essere in due che uno solo» (Qo 4,9), scrive il saggio Qoelet.
Quando, invece, non siamo disposti alla condivisione collettiva rimaniamo poveri nella conoscenza, serrati nel nostro mondo illusorio, incapaci di vedere, comprendere e discernere realmente ciò di cui siamo attorniati, finanche spegnendo l’empatia e divenendo impassibili, apatici, malinconici, egoisti e ignavi.
Ruvo del Monte, 27 luglio 2025.
______________________________
1 Aristotele, (Stagira, 384 a.C. – Calcide, 322 a.C.), è un filosofo greco antico.
2 Le Odi, scritte da Quinto Orazio Flacco a partire dal 30 a. C, sono costituite da centotre poesie raccolte in quattro libri. Il modello dell’opera è la grande poesia greca del periodo arcaico.
3 Quinto Orazio Flacco, (Venosa, 8 dicembre 65 a.C. – Roma, 27 novembre 8 a.C.), è un poeta romano.
Pubblicazione:
Domenica 27 luglio 2025, 17:30
Copyright © 2024 Strada Facendo di Michele Donato Grieco ® Tutti i diritti sono riservati.
Ferrieri web